| |
CHI SIAMO
CHI SIAMO
Nel gennaio 2005 usciva il primo numero di Prospettiva Marxista.
Da allora, i compagni che le hanno dato vita e quelli che via via si sono aggiunti, con la loro passione hanno sviluppato un lavoro editoriale concretizzatosi in centinaia di articoli (molti dei quali raccolti in volumi) su decine di tematiche nella rivista, innumerevoli denunce e commenti su fatti di attualità nella rubrica Loro e Noi, decine e decine di documenti di approfondimento pubblicati sul sito e, non ultimo, la regolare produzione e distribuzione di fascicoli in cui sono ripresi e commentati articoli della stampa italiana e internazionale.
Costante il lavoro di conferenze in sede o in luogo pubblico e la partecipazione ad iniziative di lotta o di approfondimento con altre realtà italiane ed estere.
Questi anni di intenso lavoro militante ci hanno pienamente confermato la validità e l’imprescindibilità del marxismo come metodo e impianto per analizzare e comprendere la realtà imperialistica.
Scrivevamo nel 2005:
«I compagni che si sono raggruppati intorno alla testata Prospettiva Marxista si propongono di utilizzare gli strumenti concettuali del marxismo per analizzare le dinamiche della società capitalistica e gli sviluppi delle relazioni tra Stati e potenze imperialistiche, cercando così di contribuire al rafforzamento delle fondamenta di una politica proletaria all’altezza dei compiti e dei problemi del nostro tempo.
La definizione stessa degli obiettivi che ci proponiamo e le modalità con cui cerchiamo di perseguirli derivano in gran parte dal bilancio della nostra esperienza politica. Le lacune e i limiti che abbiamo riscontrato nelle organizzazioni politiche in cui abbiamo militato non ci hanno spinto alla rassegnazione e all’abbandono dell’impegno politico. Anzi, con l’iniziativa di Prospettiva Marxista intendiamo contribuire all’arricchimento e alla capacità di orientamento di una “scuola marxista” che, al di là delle sue specifiche componenti, ci sembra attraversare una fase critica.
La componente prevalente del nostro raggruppamento proviene dall’esperienza di Lotta Comunista da cui si è distaccata attraverso percorsi confluiti nella constatazione del mancato riconoscimento, nei fatti, del principio della libertà di ipotesi scientifica. Principio questo che, lungi dall’essere relegabile tra i vezzi intellettualistici, significava e significa per noi una fondamentale garanzia di continuità con l’impostazione scientifica del marxismo e di coerenza per la vita interna di un’organizzazione che al marxismo si richiama. Abbiamo potuto sperimentare come la negazione della libertà di ipotesi scientifica, la negazione della possibilità di avanzare, avvalendosi degli strumenti concettuali del marxismo e assumendo come unico parametro di verifica lo svolgimento dei processi reali, ipotesi che avessero una piena dignità nella vita di partito, impoverisca inevitabilmente il processo di formazione dei quadri e annulli la possibilità di dare vita ad un confronto capace di garantire meccanismi di integrazione e correzione dell’analisi elaborata centralmente.
Ci siamo impegnati, quindi, a cercare di impostare, contribuendo a dare vita alla testata Pagine Marxiste, un lavoro politico che potesse nel tempo creare le condizioni per cercare di assolvere quei compiti di chiarimento teorico, di analisi, di orientamento politico che tuttora riteniamo prioritari e che ritenevamo non più assolti dall’organizzazione da cui provenivamo.
All’interno del gruppo riunitosi intorno a Pagine Marxiste sono andate, però, sempre più riemergendo difficoltà e resistenze a riconoscere una reale libertà di ipotesi scientifica. Ancora una volta, la necessità di un pieno riconoscimento della libertà di ipotesi scientifica si è scontrata con criteri di salvaguardia di un’omogeneità intesa non tanto come un risultato da conseguire, laddove possibile, attraverso un sereno confronto, condotto alla luce del sole tra militanti marxisti, ma come una sorta di unità di facciata con cui schermare un dibattito interno inteso come unico spazio per ipotesi e riflessioni che non dovessero incontrare l’unanime consenso all’interno del raggruppamento. La separazione e l’avvio di un nuovo percorso politico si sono presentati come l’unica opzione coerente.
Oggi, il compito che ci proponiamo nell’immediato è contribuire ad innalzare, nei limiti delle nostre possibilità, il livello della riflessione all’interno di quell’eterogeneo universo che possiamo convenzionalmente chiamare sinistra di classe, favorendo un più chiaro inquadramento dei processi che attraversano la formazione economico-sociale capitalistica e i termini delle sfide che il proletariato è e sarà chiamato ad affrontare. Sarà nostra cura cercare di preservare il più possibile questo nostro contributo da tutti quei vizi derivanti da logiche “di bottega”, da quegli unanimismi mortificanti con cui, purtroppo non di rado, si scambia lo “spirito” o la “disciplina” di partito. Ci auguriamo, anzi, che da un ampio, sereno e aperto confronto nell’alveo della scuola marxista possano scaturire uomini, tesi e progetti capaci di elevare la coscienza e la forza politica della classe».
…E in occasione del bilancio di un decennio:
«[…] L’analisi e l’elaborazione di ipotesi sul “ciclo politico europeo”, apertosi con la fine dell’ordine di Yalta e la riunificazione tedesca, ha rivestito un ruolo fondante nel processo formativo del nostro raggruppamento. Intorno a questo tema è ruotato il lavoro di chiarimento, sfociato nella scissione dalla formazione politica da cui il nucleo originario del nostro raggruppamento proveniva, Lotta Comunista. Lo spessore teorico della questione, l’importanza che essa riveste nella formulazione delle ipotesi del divenire del confronto tra metropoli imperialistiche, hanno consentito a quel percorso di separazione, di prima definizione di un’autonoma struttura di lavoro, di esprimere i tratti di una preziosa fase formativa per i militanti coinvolti, conferendo all’avvio del lavoro un’impronta profonda di comprensione, adesione e assimilazione del metodo marxista. Comprensione, adesione e assimilazione che sottintendono la piena consapevolezza di rivolgersi al marxismo con l’umiltà del militante che sa che la propria crescita teorica e la propria corretta applicazione del marxismo non sono mai un dato acquisito per sempre. Quest’impronta ha costituito senza dubbio uno degli elementi fondamentali che ci hanno consentito di attraversare, come piccolo ma coerente soggetto rivoluzionario, anni caratterizzati da una perdurante stabilità del dominio borghese e di costante debolezza e passività della nostra classe nel suo complesso. […] Sul piano del confronto con la politica borghese, il dato, che potrebbe apparire a prima vista come del tutto vantaggioso, della scomparsa di fatto di un effettivo opportunismo non può nascondere che la ragione di questa mancanza è l’affievolimento, che rasenta la scomparsa, della necessità per la borghesia italiana di un opportunismo che controlli e dirotti la lotta proletaria. Si conferma, quindi, e si conferma con un ulteriore decennio alle spalle, il compito prioritario di formare alla teoria marxista, di educarsi ed educare alla capacità di cogliere le contraddizioni intime della formazione capitalistica e la necessità storica della soluzione rivoluzionaria, attraverso la lente della teoria. Se infatti la dimensione teorica è in ogni fase un elemento centrale e imprescindibile della militanza marxista, in un quadro sociale segnato da una perdurante assenza di ampi e prolungati fenomeni di lotta proletaria e di momenti di crisi della tenuta del potere borghese, la chiave di comprensione teorica delle leggi del capitalismo diventa pressoché l’unico passaggio per incamminarsi verso un’effettiva consapevolezza della fondatezza storica della prospettiva rivoluzionaria. […] Abbiamo deciso, quindi, di rivolgerci all’area politica che percepivamo come più affine per storia, per valutazioni su alcune questioni nodali della teoria marxista e della vicenda del movimento operaio internazionale. Pensavamo, solo per citare uno degli ambiti più significativi su cui speravamo di convogliare le energie disponibili, di trovare un terreno comune e utili contributi in un lavoro di approfondimento e di chiarimento delle origini, dei presupposti e delle ragioni delle specifiche forme e della specifica efficacia della controrivoluzione stalinista. Tema che poi abbiamo sviluppato ne Il nemico non visto. Ci siamo mossi, quindi, cercando si stabilire contatti, collaborazioni, con le più varie espressioni di quello che, con un termine impreciso ma che è utile per intendersi, si è soliti definire il “bordighismo”. Da questo punto di vista il bilancio, è inutile nasconderlo, è disastroso. Sarebbe inutile, nel solco della nostra riflessione di bilancio, dilungarci sui tanti casi in cui abbiamo visto il contatto sfumare quasi sempre per una indisponibilità o per una ormai acquisita incapacità di porsi sul terreno di un lavoro militante per la formazione del partito rivoluzionario, pur tanto omaggiato nella sua decantata indispensabile funzione. […] Le degenerazioni, le involuzioni che abbiamo visto, sperimentato e, quando ci è stato possibile, contrastato, non possono essere ridotte alla perversa azione di individualità sviate o corrotte. Sono la manifestazione della forza di condizionamento che in una fase controrivoluzionaria, per di più dalla durata inedita, il capitalismo è in grado di esprimere. Sono il risultato dell’energia con cui gli anticorpi dell’organismo capitalistico possono aggredire, con le modalità più varie, i soggetti rivoluzionari che si muovono nei suoi tessuti. Non siamo in nessun modo immuni da questa influenza, dai rischi di degenerazione e di abbandono del marxismo. Ma il marxismo ha anche dimostrato, in un arco di tempo che accomuna ormai una pluralità di generazioni, che può costituire un’arma, uno strumento formidabile di lettura della realtà e di azione in essa. Garantirsi il possesso di quest’arma è la sfida della formazione dei quadri, dell’educatore che si educa nell’educare. Della capacità di raccogliere questa sfida è parte integrante e centrale il lavoro per questa rivista e la sua pubblicazione, rivolta specificatamente alla formazione di quadri. […]».
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
RIFLESSIONI SULLA QUESTIONE DEL PARTITO
Nella storia del movimento comunista, la questione del partito figura senza dubbio tra le più delicate e controverse. Correnti, filoni di pensiero, soggetti politici intorno a questo tema si sono confrontati e scontrati.
Al cuore del problema vi sono domande apparentemente semplici eppure gravide di fondamentali implicazioni: cos'è, quali funzioni ha, come deve essere composta e deve agire un'entità politica il cui significato storico è indissolubilmente legato alla dimensione collettiva, di massa, spontanea, della classe proletaria ma che in quanto tale non può condividere pienamente le caratteristiche di quest'ultima? Quali nessi devono unire il partito e la classe nel suo insieme? Quale specifica funzione rivoluzionaria deve assolvere un'entità come il partito rispetto ad un processo rivoluzionario che non può che avere come fattore storico essenziale il moto di massa della classe sfruttata? Sono domande riconducibili, in sintesi, al punto focale del rapporto tra forza di classe e teoria rivoluzionaria. Certo, c'è stato chi, di fronte all'importanza della questione, ha creduto bene di aggirarla, postulando la sua non esistenza. Di qui i vari filoni ideologici sull'inutilità del partito, sull'esperienza di classe capace nella lotta di pervenire alle conoscenze politiche sufficienti per svolgere appieno un ruolo rivoluzionario, sul partito che non può che essere il prodotto immediato, diretto, della lotta della classe, sul partito che si identifica tout court con la classe etc. etc. In realtà il marxismo è pervenuto alla formulazione coerente del partito. È nel nucleo teorico del Che fare? di Lenin. Il punto è che questa acquisizione va continuamente difesa, riaffermata, riappropriata. Sono infatti andate stratificandosi intorno a questo nucleo coltri di letture fuorvianti, di falsificazioni, di distorsioni ideologiche. É destino inevitabile del pensiero rivoluzionario. Ma si è arrivati al punto che il concetto leniniano di partito, così profondamente organico all'insieme dell'impostazione teorica marxista, è spesso giudicato e rifiutato prima ancora che sia conosciuto e capito. É giudicato e rifiutato in base alle sue rappresentazioni consuete, in base alla vulgata entro cui è stato racchiuso. Si è persino cercato di condannarlo in base a parametri del tutto estranei come quello del tasso di democraticità, della sua capacità di esprimere le volontà e le opinioni di maggioranze e di orientamenti prevalenti nella classe. Si è arrivati a farne il piedistallo organizzativo della successiva controrivoluzione stalinista, come se questo processo storico terribile ed epocale fosse il parto di degenerazioni organizzative e non il risultato di dinamiche profonde tra classi. Al colmo del paradosso, si è tentato addirittura di assolverlo proprio in base ad una sua presunta intrinseca democraticità, da contrapporre allo stalinismo ancora una volta in un confronto giocato sulla dicotomia metafisica tra democrazia e dittatura. Destino non casualmente analogo ha conosciuto il concetto scientifico di dittatura del proletariato. Ora bollato come peccato originale del regime stalinista e degli altri "socialismi reali" ora apparentemente difeso con la relativizzazione della sua autentica natura dittatoriale, riducendolo ad infelice espressione linguistica per una super-democrazia nei fatti. In entrambi i casi un concetto che ha la sua vita autentica solo nel quadro della complessiva impostazione marxista, estranea ed ostile alle categorie politiche borghesi, è stato stravolto proprio per renderlo deprecabile o accettabile attraverso il filtro di un'interpretazione poggiante su interessi di classe in realtà incompatibili con la sua essenza teorica.
Lenin invece ha affrontato da marxista il nodo del rapporto tra teoria rivoluzionaria e azione rivoluzionaria della classe. Il fulcro della sua risposta è nella formulazione del partito di quadri. Un partito che non può che essere il nucleo politicamente cosciente, teoricamente formato, indispensabile all'azione storica rivoluzionaria, all'interno della più ampia e storicamente anch'essa indispensabile dimensione di classe. Chiunque si avvicini a questa risposta cercandovi una ricetta, uno schema, una definizione da manuale del quadro e del partito di quadri, è destinato a non capire il senso profondo di questo concetto di partito. Significato la cui individuazione e formulazione ha davvero portata storica, che risiede non nell'inesistente possibilità di evitare tensioni, lotte, degenerazioni intorno al processo reale di formazione del partito, ma nella raggiunta possibilità di affrontare queste esperienze, questi passaggi, queste sfide, con la consapevolezza, con la stella polare dell'acquisizione teorica della natura essenziale del partito, dei suoi compiti storici essenziali, delle caratteristiche basilari che ne derivano. Solo ad una lettura estremamente superficiale questo può apparire poco. Nella prassi plurigenerazionale del movimento rivoluzionario è un salto di qualità straordinario, una scoperta scientifica.
Nel sottolineare la valenza del concetto di partito di quadri, la nostra riflessione su questo tema verte sull'importanza del rapporto tra partito ed organizzazione. Se il partito è il nucleo politicamente cosciente della classe ed è composto da quadri rivoluzionari, non solo esso non coincide con la classe, ma anche chi compone la sua organizzazione, in varia misura, a seconda dei particolari periodi storici della lotta di classe, non coincide con il partito. Non solo, ma l'organizzazione, indispensabile al corretto funzionamento del partito, deve sempre essere in un rapporto tale con il partito da consentire a quest'ultimo di dirigerla e controllarla effettivamente. L'organizzazione deve essere sempre in funzione del partito, della sua esistenza e azione quale guida teorica della classe. In caso contrario l'organizzazione ha preso il sopravvento e i suoi criteri di incremento e di efficienza hanno assunto vita propria rispetto ai criteri del partito. Il partito ha così cessato di esistere. Soltanto la corretta tensione dialettica tra partito ed organizzazione, tra quadri e non quadri all'interno della più ampia azione di partito, è garanzia di sopravvivenza e sviluppo del movimento rivoluzionario nel suo complesso.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
TRA PARTITO E CLASSE
La questione del partito non può che portare con sé la questione dei rapporti tra il partito rivoluzionario e la sua classe di riferimento.
Negare questa problematica, riducendo il partito a mera appendice della classe, a semplice prodotto e ricaduta delle sue dinamiche e lotte, significa in realtà negare alla radice la questione del partito. Poiché significa presupporre che la dinamica spontanea di un ciclo di lotta possa puntualmente comportare per la classe sfruttata l'acquisizione di un bagaglio teorico adeguato ad assolvere i suoi compiti rivoluzionari. Invece, la questione del partito, e dei suoi rapporti con la classe, si impone proprio alla luce dell'esistenza di tempi differenti, di una scansione temporale che può variare significativamente a seconda delle fasi storiche, per la prassi della lotta di classe e la teoria della lotta di classe. Demandare all'esperienza conseguibile in un ciclo di lotte la funzione di pervenire all'acquisizione teorica che può maturare solo in un più ampio processo storico non può voler dire altro che negare la funzione della teoria e, quindi, del partito. Ma accettare il ruolo cruciale del partito pone inevitabilmente il compito di individuare come il partito possa instaurare con la classe un legame che sia in grado di consentire alla teoria organizzata di svolgere la propria vitale funzione nel processo rivoluzionario. Tale legame non può, se effettivamente si affronta la questione della teoria in grado di agire nella forma partito come fattore storico rivoluzionario, risolversi in una formula unidirezionale. Collegare il partito alle dinamiche, alla vita della classe, è condizione non solo perché la minoranza politica che rappresenta la teoria rivoluzionaria possa trasmettere ad una più ampia dimensione di classe gli elementi della coscienza politica rivoluzionaria. È condizione anche perché la minoranza organizzata chiamata a perseguire i compiti del partito possa a sua volta apprendere dall'esperienza di classe, verificare, arricchire, affinare la propria assimilazione teorica, mettendosi così veramente in condizione di assumere il ruolo di avanguardia politica del proletariato.
Porsi realmente il problema del rapporto tra partito e classe comporta necessariamente andare oltre la generica categoria di classe, la sua indistinta dimensione di massa, per sforzarsi di inquadrare in che termini concreti, storici, può determinarsi un terreno comune e di congiunzione tra le due forze. Da questo punto di vista, l'esperienza storica e la conseguente elaborazione teorica della scuola marxista ci mostrano come in realtà la questione del rapporto tra partito e classe si traduca piuttosto nel rapporto tra partito e lotta di classe. Ad un grado ulteriore di specificazione: tra partito e organismi che la classe esprime nella sua lotta. La cruciale questione può quindi uscire dalle nebbie delle dichiarazioni di principio che non si risolvono in un'indicazione di lavoro politico, delle formule altisonanti ma vacue, e diventare il presupposto di metodo per affrontare un indispensabile compito politico: mettersi nelle condizioni per riconoscere il momento, le forme specifiche con cui la classe esprimerà spontaneamente quegli organismi intorno a cui si svolgerà la determinante battaglia politica perché il partito conquisti il ruolo di guida della lotta proletaria.
Ecco, quindi, come nella capacità di individuare, di cogliere lo spazio storico, organizzativo, politico che si colloca tra partito e classe, e di agire in esso come teoria-guida per l'azione, si concretizza la sfida del partito, di essere effettivamente partito.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
CRISI E LINEE DI FAGLIA
Interpretando i rapporti economici come semplici rapporti tra individui e cose, l'economia borghese non riesce a concepire le categorie economiche nella loro storicità, considera il denaro, il salario, il capitale elementi universali, categorie eterne, non storicamente determinate da uno specifico modo di produzione.
Per il marxismo invece il sistema capitalistico è un fenomeno storico, un modo di produzione nato in una particolare fase dello sviluppo umano, evolutosi e sviluppatosi nella fase successiva e destinato, al verificarsi di certe condizioni, ad essere superato da una nuova forma di organizzazione sociale. Risulta quindi inevitabile, per la scuola marxista, affrontare il tema del destino del capitalismo, delle modalità e dei tempi del suo sviluppo e delle sue crisi.
Rifiutiamo l'impostazione teorica che ha preso piede in alcuni ambiti marxisti e che, concentrandosi quasi esclusivamente sulle leggi di funzionamento economico del capitalismo, ritiene il modo di produzione borghese, raggiunto un certo livello di sviluppo, incapace di riprodurre valore, autocondannandosi inevitabilmente al crollo.
Solo l'azione soggettiva della classe oppressa, può, se vittoriosa, portare al superamento del modo di produzione capitalistico, ma tale azione si manifesta al verificarsi di talune, particolari e determinate condizioni.
Senza una situazione rivoluzionaria non ci può essere rivoluzione. Ma cosa rende una situazione di crisi una situazione realmente rivoluzionaria? Perché una crisi possa aprire la finestra rivoluzionaria, ci ricorda Lenin, devono manifestarsi, compenetrandosi tra di loro, alcuni elementi:
- una crisi politica della classe dominante che mette in discussione la sopravvivenza del suo dominio,
- un inasprimento delle condizioni di vita delle masse capace di spingere il proletariato verso una più attiva e incisiva azione politica,
- l'azione cosciente del partito rivoluzionario che, organizzando il malcontento delle masse proletarie, pone all'ordine del giorno la presa del potere.
Senza la compresenza, indipendente dalla volontà, di questi elementi, lo sbocco della crisi rimane all'interno della cornice borghese, produce al massimo un ricambio politico interno alla borghesia che non mette in discussione il potere dello Stato e i rapporti capitalistici esistenti.
La crisi capace di aprire la prospettiva rivoluzionaria è, al contempo, una crisi economica, sociale e politica. Se facciamo riferimento alle punte più avanzate di lotta ed emancipazione del proletariato, la Comune di Parigi e le rivoluzioni russe, possiamo costatare come la rivoluzione sia stata indotta da crisi politiche scoppiate col maturare di contraddizioni emerse a livello internazionale (la guerra franco-prussiana, il conflitto russo-giapponese e la Prima guerra mondiale) e come guerra e rivoluzione siano elementi strettamente correlati tra loro.
La guerra non è in contraddizione con lo sviluppo capitalistico, ma è la conseguenza diretta e inevitabile di tale sviluppo. In regime capitalistico la spartizione del mercato mondiale avviene tramite la forza politica, economica e militare degli imperialismi, ma la forza cambia nel corso dello sviluppo economico. Non è possibile un ritmo uniforme di sviluppo, né per le singole aziende, né per i singoli Stati. Sempre secondo Lenin: « Non sono possibili altri mezzi per ristabilire di quando in quando l'equilibrio scosso all'infuori della crisi nell'industria e della guerra nella politica». Guerra e rivoluzione sono aspetti di uno stesso fenomeno prodotto dallo sviluppo ineguale del capitalismo. La teoria della crisi si lega di conseguenza all'analisi dei rapporti internazionali tra potenze e alla prospettiva bellica e militare. È necessario indagare i rapporti di potenza, valutare i rapporti di forza tra imperialismi, individuare quegli Stati che, ascendendo o indebolendosi, possono aprire nuove aree di crisi. Il marxismo non si può esimere dal provare ad individuare quelle tendenze, inserite nello sviluppo ineguale del mercato mondiale, che, mutando i rapporti di potenza, potranno aprire quei fronti di rottura, quelle linee di faglia capaci di creare le condizioni oggettive su cui l'azione soggettiva del partito potrà inserirsi.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
LA QUESTIONE EUROPEA
Nell'analizzare le differenti fasi del processo politico europeo abbiamo cercato di inquadrare i diversi avvenimenti basandoci su fatti oggettivamente riscontrabili, cercando di individuare le forze determinanti e quelli che potevano essere gli esiti concreti.
La nostra chiave di lettura della situazione continentale, delle relazioni all'interno dell'Unione europea, non poteva e non può prescindere dalla lotta delle classi e delle frazioni di classe, un fattore per noi persistente che determina le diverse forme politiche. Lotta tra borghesie, tra frazioni borghesi e tra compagini statali erano e rimangono il perno di un processo politico europeo in divenire. Persiste in Europa un frazionamento nazionale e un perseguimento di differenti interessi nazionali, ciò ha generato e genera le fasi delle lotte politiche che attraversano il continente. Sull'onda dell'unificazione tedesca, del varo della moneta unica, si era diffusa una rappresentazione del processo politico europeo come una locomotiva destinata a viaggiare, senza significativi ostacoli, verso la ormai certa meta dell'unificazione. Questo corso storico tendeva ad essere presentato come una marcia trionfale, un percorso nitido, rettilineo, ispirato dalla raggiunta consapevolezza delle esigenze e dei compiti di una competizione mondiale imperniata su soggetti imperialistici dalla stazza continentale. I passaggi fondamentali di un processo d'integrazione venivano salutati con un'euforia che, soprattutto in Italia, metteva in ombra il lato dello scontro e della lotta tra le capitali europee. In realtà eravamo di fronte ad un quadro ideologico che rifletteva rapporti di forza tra Stati, tra borghesie. Le varie ideologie europee sono funzionali alle diverse frazioni borghesi per imporre una propria visione dell'Europa, una formulazione delle relazioni europee che sia corrispondente agli specifici interessi. Gli esiti del confronto tra potenze, il mutare dei rapporti di forza nel contesto imperialistico interno ed esterno all'Europa determinano in ultima analisi i mutamenti di fondo del clima ideologico generale. Ma in quella fase in cui le ideologie prevalenti offuscavano la lotta tra Stati nel teatro europeo, per noi era fondamentale fare chiarezza, mettendo in luce con il metodo marxista i nodi e le contraddizioni fondamentali della questione europea. Riconoscemmo che la fine di Yalta, l'emergere di potenze come la Cina, stavano segnando una nuova fase della competizione imperialistica globale, ponendo anche le potenze europee di fronte a sfide epocali. Ma tutto questo non poteva produrre un fatale automatismo, un percorso che portava inevitabilmente ad un finale già scritto, ad una tendenza che non teneva conto delle forze reali e delle contraddizioni insite nelle relazioni tra gli Stati europei. L'avverarsi dello schema delle borghesie europee, storicamente pervenute alla forma dello Stato nazionale ma capaci di rinunciare spontaneamente ad un organismo statuale di cui sono esclusive titolari, per confluire in una superiore entità politica di cui non avrebbero potuto detenere il pieno controllo, in nome della raggiunta consapevolezza del superiore interesse europeo a fronte della sfida di altri imperialismi, avrebbe comportato un caso inedito nella storia della formazione degli Stati in epoca capitalistica. Un precedente che avrebbe imposto un profondo ripensamento, nella strategia rivoluzionaria, delle potenzialità e del livello di coscienza raggiungibili dalla classe borghese. Il reale corso storico ha invece confermato come un processo di formazione di uno Stato europeo superiore alle varie sovranità nazionali non sia questione attinente all'affermazione della consapevolezza dell'interesse di un'astratta borghesia europea, ma alla lotta tra gli interessi specifici delle borghesie europee, alla possibilità di emersione di una forza capace di imporre la propria formulazione di unificazione, nel quadro degli sviluppi del confronto imperialistico globale. Abbiamo visto l'emergere di una nuova Germania, che da gigante essenzialmente economico è diventata un protagonista politico. Abbiamo colto il cambiamento dei rapporti interni all'asse franco-tedesco. Il punto di svolta si è manifestato con la guerra irachena del 2003. Il no tedesco all'iniziativa statunitense vide la borghesia francese muoversi non più come guida politica dello storico motore europeo. Il confronto si risolse in una pesante battuta d'arresto del tentativo dell'asse tedesco-franco di compattare una coalizione di Stati europei attorno alla propria opposizione all'intervento di Washington. Veniva confermato il ruolo degli Stati Uniti come potenza europea in grado di contrastare l'azione centralizzatrice di una potenza continentale.
Altro elemento cardine della nostra analisi sulle dinamiche europee è costituito dalla moneta unica. Contro la tesi della moneta unica come espressione, e insieme irresistibile propellente di ulteriori passi avanti, di quel processo di convergenza degli imperialismi europei lungo la direttrice che avrebbe portato al futuro Stato comune, abbiamo individuato nell'euro proprio il risultato e la manifestazione delle dinamiche di scontro, alleanza, contenimento, generate dalla perdurante realtà delle potenze nazionali europee e del loro interagire. Dinamiche, tensioni, che dopo la fine di Yalta conoscevano una nuova fase ed un'accelerazione. La concreta adozione dell'euro si materializzò come un passaggio imposto alla Germania in corso di riunificazione: Berlino poteva aspirare al raggiungimento di un superiore status politico e fare un salto di qualità nella lotta imperialistica mondiale se accettava di incardinare la sua forza economica, sintetizzata nel marco, in un assetto di contenimento su scala europea. Ma questo accordo, di fatto alle basi della moneta unica, non poteva rappresentare una pietra tombale sulla conflittualità interimperialistica in Europa. Se la Germania accettava di condividere a livello europeo la gestione della moneta unica, al contempo conduceva una battaglia, sempre più evidente, per imporre il segno tedesco a questa gestione comune. La questione dell'unificazione politica dell'imperialismo europeo, con i suoi nodi della formazione di un fisco, di un esercito, di una politica estera effettivamente sovranazionali, si ripropone, quindi, intimamente intrecciata con la questione tedesca. Con la confermata tendenza tanto della Germania ad assumere un ruolo egemone in Europa quanto al sorgere di alleanze e spinte contrastanti questo ruolo. Un processo di unificazione politica europea non potrà mettere tra parentesi al suo interno la propria natura imperialistica per limitarsi a proiettarla all'esterno. Al centro della realtà della lotta intorno all'integrazione europea permane il nodo della forza, della forza in grado di guidare questo processo, imponendosi su altre opzioni imperialistiche di unione continentale e su centrali imperialistiche ostili all'unificazione. La questione della forza degli Stati borghesi continua a ribollire nel "calderone delle streghe" europeo.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
LA MATURAZIONE PARASSITARIA DELL'IMPERIALISMO
Concentrandoci sul concetto di parassitismo, per individuare un segno determinante dello stadio di avanzata maturazione imperialistica delle "storiche" realtà capitalistiche mondiali, non abbiamo inventato nulla.
Possiamo infatti ritrovare nella scuola marxista la chiara consapevolezza di come, entro i termini e le categorie del modo di produzione capitalistico, accanto alla forza-lavoro impiegata nella produzione di merci e nella formazione del plusvalore esistano figure, componenti sociali che, pur non detenendo i mezzi di produzione, sfuggono al ciclo di produzione del plusvalore. La distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo, chiaramente presente e sviluppata nel pensiero marxista, si ripropone come questione di centrale importanza nel quadro dei capitalismi a più vecchio sviluppo imperialistico. Non a caso, inoltre, l'esplicito richiamo ai tratti parassitari del capitalismo si ritrova nell'Imperialismo di Lenin. L'ulteriore avanzamento della connotazione imperialistica dei maggiori capitalismi non ha fatto altro che accentuare questo tratto parassitario, rendendo ancora più acuto il problema, già individuato, da Lenin della sua sostenibilità.
La questione della massa e della ripartizione del plusvalore, che rimane al cuore del modo di produzione capitalistico, è entrata così sempre più in contraddittoria relazione con l'incremento, nella maturazione imperialistica di alcune realtà persino esponenziale, di strati sociali che consumano plusvalore senza partecipare alla sua produzione. È una questione nevralgica che contiene in sé il problema dell'incremento della produttività del lavoro e quello della quota di plusvalore mondiale che ognuna delle centrali imperialistiche riesce ad assicurarsi, posti in relazione con gli sviluppi di quel fenomeno sociale che è il parassitismo nel sistema capitalistico. È nostra convinzione che la criticità di questo rapporto sia un elemento fondamentale di quella situazione spesso definita in termini sommari e sbrigativi come "crisi mondiale del capitalismo". Questo rapporto non si pone negli stessi termini in tutte le realtà capitalistiche mondiali così come differenti saranno i suoi sviluppi e i suoi effetti in termini di lotta sociale e politica. Infatti, identificare il fenomeno dell'incremento parassitario come contrassegno dell'imputridimento imperialistico non equivale né ad esprimere una condanna morale né a rilevare un mero dato statistico. L'aumento della componente parassitaria nel contesto della società imperialistica è questione cruciale che si impone all'attenzione dei soggetti politici che perseguono una strategia rivoluzionaria. Parassitismo, che è definibile come tale solo in rapporto al ciclo di produzione di plusvalore, può significare anche masse di lavoratori che nei fatti vivono in condizioni proletarie, di disoccupati e di sottoccupati. Ma la loro connotazione parassitaria diventa inevitabilmente presupposto materiale, con l'oggettiva dipendenza da canali (con un ruolo tendenzialmente prevalente dello strumento fiscale dello Stato) di distribuzione di plusvalore ottenuto altrove, per una prassi sociale, una determinata percezione diffusa, una specifica psicologia collettiva, che possono distinguersi molto dalle situazioni proletarie di precedenti fasi storiche e rivestire un significato critico e problematico nel rapporto con la teoria e l'azione rivoluzionaria. Ecco allora che la questione del parassitismo nella fase di estrema maturazione imperialistica si ritaglia uno spazio centrale tanto nelle dinamiche di spartizione del plusvalore mondiale e di accelerazione delle tensioni tra centrali imperialistiche quanto nel divenire dei rapporti e degli antagonismi, sociali e politici, all'interno dei singoli imperialismi. Un intreccio che può scandire in maniera determinante i tempi sia della maturazione di una conflagrazione tra imperialismi sia delle scadenze della formazione di una soggettività rivoluzionaria in grado di adempiere ai suoi compiti indispensabili in una realtà capitalistica compresa nei suoi specifici tratti contemporanei.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
ALLE RADICI DELLA CONTRORIVOLUZIONE STALINISTA
Tra i pochi che oggi si sforzano di riallacciarsi al marxismo e alla sua traduzione storica, si è soliti indicare l'azione dello stalinismo tra le cause dell'attuale stato di debolezza del movimento operaio e delle sue organizzazioni.
In tutto ciò indubbiamente c'è del vero, tuttavia, inserita in una riflessione di più ampio respiro storico, la controrivoluzione stalinista presenta ancora importanti interrogativi. Spiegare infatti la debolezza di un movimento rivoluzionario con l'azione della controrivoluzione è di per sé troppo poco. Pare lapalissiano che il mestiere delle controrivoluzioni sia quello di reprimere le rivoluzioni, ma ciò non significa che questa azione possa di per sé condannare il movimento rivoluzionario ad uno stato di prostrazione plurigenerazionale. Alla luce delle esperienze precedenti, infatti, non è vero che la vittoria di una controrivoluzione sia necessariamente in grado di ridurre ai minimi termini un movimento rivoluzionario, per un lasso di tempo così prolungato, come invece lo stalinismo è riuscito a fare. Pensiamo ad esempio alla Restaurazione dopo la sconfitta di Napoleone, che non è riuscita, quale controrivoluzione assolutistica, a frenare il movimento rivoluzionario borghese, o alla sconfitta della Comune di Parigi, che non ha di certo messo in ginocchio per decenni lo sviluppo del movimento socialista.
È quindi da registrare come lo stalinismo, rispetto ad altre esperienze controrivoluzionarie, sia stato avvantaggiato da fattori che ne hanno reso più efficace l'azione e più profonda l'influenza. Anche l'analisi di Bordiga, che inquadra la sconfitta della rivoluzione di Ottobre nella mancata rivoluzione internazionale e a questa sconfitta riconduce l'affermazione dello stalinismo, non perviene all'individuazione dell'errore teorico quale condizione per l'inedita e straordinaria, per intensità e durata, esperienza della controrivoluzione stalinista.
Sicuramente una caratteristica che salta all'occhio e che non ha precedenti negli altri movimenti controrivoluzionari, è l'appropriazione da parte dello stalinismo delle forme, dei richiami nonché addirittura delle stesse organizzazioni espresse dal movimento rivoluzionario. Caratteristica questa che, in oggettiva sinergia con i capitalismi dichiarati d'Occidente, ha indubbiamente conferito un surplus di forza controrivoluzionaria. Se infatti risaliamo ai precedenti fenomeni controrivoluzionari, stentiamo a trovare controrivoluzioni che, nella loro azione, si richiamano agli ideali e ai progetti della rivoluzione. Il risultato di questa peculiarità è che mentre la controrivoluzione nelle sue forme classiche (siano esse fasciste, clericali, democratiche o comunque dichiaratamente anticomuniste) veniva compresa, quella stalinista faticava ad essere percepita come tale anche dalle punte più avanzate del movimento comunista. L'analisi posta in essere da Trotskij è esemplare in questo senso: partendo dallo schema di Lenin che vedeva il capitalismo di Stato come forza alleata al socialismo in contrapposizione alla borghesia contadina e al capitale privato, Trotskij non mostra, nel farlo proprio, quelle increspature di riflessione, quel sentore di pericolo che Lenin avverte nell'ultima fase della sua esistenza. Addirittura, con l'allontanarsi della prospettiva di un processo rivoluzionario mondiale, Trotskij nel 1926 afferma che il capitalismo di Stato russo potrebbe, grazie al suo intenso sviluppo di forze produttive nelle mani del potere del proletariato rivoluzionario, garantire la conservazione di quest'ultimo per altri 50 anni, in attesa della ripresa del ciclo rivoluzionario. Il mancato sviluppo qualitativo delle potenzialità socialiste del sistema sovietico nonostante il salto quantitativo delle forze produttive, inducono Trotskij, coerentemente con la sua impostazione, a spiegare il fenomeno rilevando gli elementi di distorsione che hanno impedito il corso previsto, individuando così nella burocrazia la componente sociale capace di caratterizzare quella forma ibrida di ordinamento che verrà definita Stato operaio degenerato. Il marxista Trotskij, dunque, non riesce a scorgere nello stesso capitalismo di Stato russo, inserito in un contesto internazionale di impossibilità oggettiva al prosieguo del ciclo rivoluzionario, la radice del problema. Un capitalismo di Stato, riconosciuto come capitalismo a tutti gli effetti seppur in ritardo da Bordiga, che nel giro di un decennio dall'Ottobre, esprime i suoi uomini, il suo apparato dirigente, le sovrastrutture atte alla propria conservazione ed elimina le ultime avanguardie rivoluzionarie in quanto non in sintonia con le proprie esigenze materiali. Lo sviluppo del capitalismo di Stato cessa quindi di rivestire una funzione di supporto al proletariato in attesa del congiungimento con la rivoluzione internazionale, e agisce per quello che è: un pieno sviluppo capitalistico, che si ricava spazi nel partito e nelle istituzioni dello Stato sovietico. La tesi del socialismo in un solo Paese, non è un semplice scivolone di cervelli poco avvezzi al marxismo, ma è il portato ideologico di una componente sociale che, in quanto pienamente e coerentemente capitalistica, non solo non ha più nulla a che fare col marxismo, ma ne è avversa.
Il partito rivoluzionario non ha creato sufficienti barriere per difendersi da quella componente sociale che aveva individuato quale alleata contro la borghesia contadina e il capitale privato, considerati invece come i principali nemici della rivoluzione. Questo "nemico non visto", questa forza oggettivamente antitetica alla rivoluzione, come già Lenin la aveva inquadrata nei suoi ultimi anni di vita, una volta conclusosi il ciclo rivoluzionario è riuscita in pochissimo tempo a snaturare il partito stesso dall'interno, lasciandone intatto l'involucro esterno.
La mancata comprensione delle radici della controrivoluzione stalinista ha impedito alle avanguardie rivoluzionarie di considerarla apertamente come tale e come tale di combatterla.
Oggi infatti lo possiamo chiaramente constatare: chiusosi lo sbocco rivoluzionario internazionale, il partito, ormai in tutto e per tutto espressione del capitalismo di Stato russo, andava combattuto. Combattuto non come corrente degenere del partito rivoluzionario, nel tentativo di porlo in minoranza all'interno di ambiti politici in cui ormai aveva vinto, ma combattuto come espressione politica del capitale, come partito della classe avversa, come nemico mortale. Questa consapevolezza è mancata nei grandi oppositori dello stalinismo, pesando sulle modalità della loro opposizione alla controrivoluzione.
Trotskij e Bordiga rientrano a pieno titolo e in prima fila nella scuola marxista, ma proprio per questo i marxisti, quali scienziati sociali, hanno il dovere di riflettere con serietà e metodo sia sugli aspetti validamente risolti della loro esperienza, sia su quelli insoluti.
Studiare e capire quei nodi irrisolti significa cogliere i frutti e gli insegnamenti conseguiti col sangue dal meglio di una generazione marxista. Capire gli errori, i loro effetti gravi nonché le ragioni di questi errori significa rafforzare il marxismo attraverso la comprensione di una sua grande esperienza storica, perché il dramma possa essere tradotto in forza.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
L'IMPERIALISMO ITALIANO
Il non cadere nelle ideologie dell'europeismo imperialista ci ha permesso di continuare a vedere l'esistenza e l'operare dell'imperialismo italiano.
I crismi dei poteri sostanziali dello Stato, per come sintetizzati da Engels nell'Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, e ripresi da Lenin in Stato e Rivoluzione, si esprimono ancora saldamente in una dimensione nazionale che rende ancora attuale la lezione di Liebcknecht, del "nemico è in casa nostra", la sola posizione che incarni effettivamente la strategia dell'internazionalismo proletario, l'unica opzione che non si riveli succube di logiche borghesi.
Riteniamo inoltre che l'imperialismo italiano abbia ancora dei tratti peculiari che lo candidano, dovessero permanere, ad essere potenziale anello debole della catena imperialista, una sorta di vaso di coccio tra vasi di ferro.
Il turbinoso sviluppo che il capitalismo italiano ha vissuto tra gli anni Cinquanta e Settanta aveva aperto le condizioni per una battaglia dei maggiori grandi gruppi industriali italiani, in alleanza con i sindacati e la spinta trade-unionistica, di tentare, attraverso quello che giornalisticamente venne chiamato "patto dei produttori", di risolvere il peso abnorme della piccola-borghesia nel tessuto strutturale della formazione economico-sociale. Quella linea, complice la ristrutturazione di metà anni Settanta, venne sconfitta e da allora si stabilizzarono sistemi di alleanze politiche che non potevano prescindere da una base materiale che si trovava nella massa piccola borghese e negli strati parassitari che via via si ampliavano, in virtù anche dei sovrapprofitti garantiti dalla crescente estrazione internazionale di plusvalore.
Sul fronte delle dinamiche politiche abbiamo assistito anche alla sostanziale estinzione, almeno quanto a presenza parlamentare, delle espressioni politiche dell'opportunismo, dei socialisti a parole e sciovinisti nei fatti, come diceva Lenin.
Il tramonto delle opzioni opportuniste trova come una delle ragioni materiali fondamentali l'esaurimento di un ciclo di lotte del proletariato che dava linfa a quelle manifestazioni politiche. L'imperialismo, in questa sua lunghissima fase espansiva, ha potuto addirittura fare a meno degli opportunisti, di coloro che servivano a contenere e indirizzare in chiave riformista le spinte della classe operaia e del proletariato, principalmente perché queste ultime sono da decenni ai minimi livelli storici registrati quanto a mobilitazioni.
Il capitalismo, nella continuità della struttura economica che Marx ha scientificamente svelato nel Capitale, ha cambiato le sue forme senza mutarne la sostanza. La classe sfruttata, quella che vive vendendo la propria forza-lavoro e che sperimenta sulla propria pelle le contraddizioni del capitalismo, si è frammentata e precarizzata nelle metropoli mature. Il lento declino economico che l'imperialismo italiano sta sperimentando ha contribuito al deterioramento della condizione proletaria, soprattutto di quelle generazioni di giovani salariati che non hanno più, come i propri genitori, la prospettiva di un miglioramento della propria condizione materiale. Le ideologie sulle "magnifiche sorti e progressive" di questo sistema mostrano finalmente la corda.
L'apporto dell'immigrazione sta infine trasformando la composizione della nostra classe che tra i suoi compiti immediati deve puntare a ritrovare la coscienza di sé e della necessità della lotta, per difendersi nell'immediato dalle angherie del capitale e per poter un domani, grazie all'apporto del marxismo e del partito rivoluzionario, superare definitivamente il capitalismo.
[ Visiona / Nascondi intero contenuto ]
|
sito comunista internazionalista legato alla testata
Prospettiva Marxista 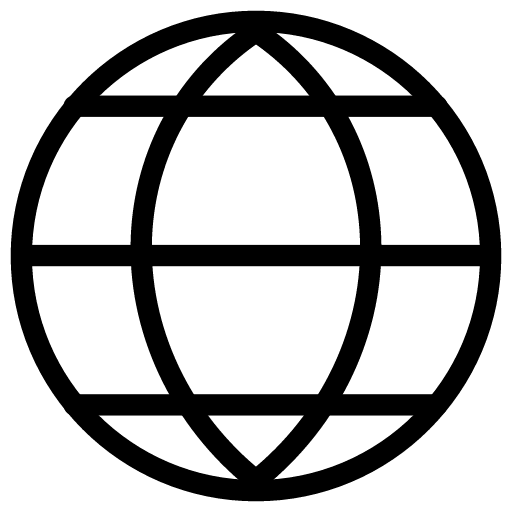
|
|
| |
|
